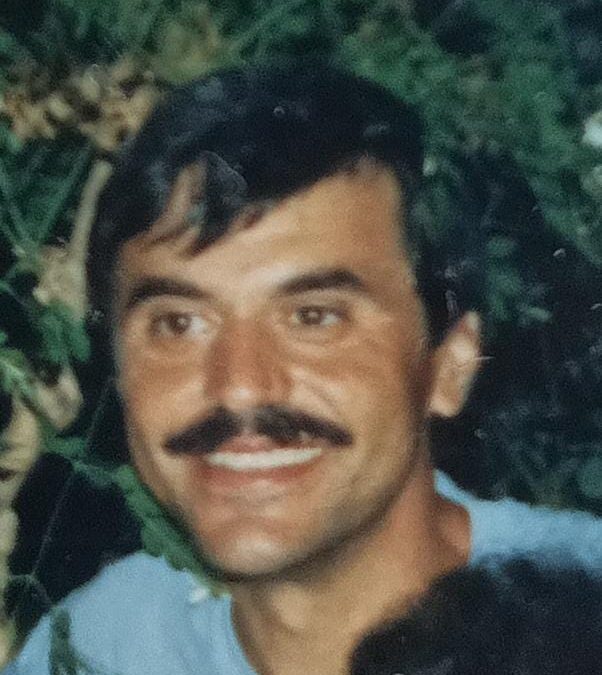LEONFORTE – Il professore Michele La Porta non è più. Lo stimato uomo di studio si è spento oggi nella sua casa di Leonforte, amorevolmente assistito dalla moglie, signora Nerina, dai figli e dai parenti più intimi.
Le sacre esequie saranno celebrate domani, 17 luglio, nella Chiesa Madre, all’altare della Beata Vergine del Carmelo, alle ore 15. Garbato, signorile, generoso, colto, è stato scrittore raffinato. L’ultima sua opera “Il figlio di Mussolini”, di cui si è occupata la nostra testata, ha riscosso un discreto successo.
Ci piace ricordarlo pubblicando un pezzo postato su Fb dal figlio, professore Nino La Porta. Leonforte perde una persona buona.
Condoglianze alla famiglia.
Il professore La Porta è stato un intellettuale garbato, appartenente a una specie – i gentiluomini – di cui, purtroppo, sembra non esservi ricambio nella attuale società. (j.t.)
Quello che segue è il testo del post.
Questa è la prima volta che mio padre si prende la scena tutta per lui. Ha passato un’intera vita dietro le quinte, a smussare angoli, togliere castagne dal fuoco, alleggerire carichi altrui. Ha concesso a me e alle mie sorelle il sontuoso privilegio di crescere tendendo sempre lo sguardo verso l’alto e verso l’altro, senza mai farci scontare ansie da prestazione, minacce, ricatti, ultimatum o coprifuochi di sorta. Ci ha dato la possibilità di sbagliare tutte le volte che ci serviva farlo, di tornare indietro quando necessario per andare avanti, di ricalcolare i percorsi, di cercare noi stessi anche lontano da lui. Quando avevo quindici anni, tra i miei coetanei di allora, fece scandalo la sua decisione di spedirmi un mese a Londra dopo aver saputo della mia bocciatura. Mentre i miei compagni di sventura passavano le loro estati a espiare la colpa – zappando in campagna, incoppando le pesche, lavorando nei bar – io me ne andavo a svernare, bello pacioso, all’ombra del Big Ben. Ma com’era possibile, si chiedevano tutti. Il fatto è che mio padre sapeva bene che punirmi in quel momento non sarebbe servito a un cazzo. Aveva intuito che avevo solo bisogno di cambiare aria, raccogliere nuovi stimoli, cercarmi altrove, fuggire un po’ dalle sabbie mobili di una mentalità di paese che mi stava divorando. Era il suo modo di dirmi che nonostante tutto lui non aveva smesso un istante di credere in me; e che prenderci una pausa l’uno dall’altro avrebbe fatto solo che bene a entrambi. Aveva ragione.
Alieno da ogni conformismo, mio padre ci ha costruiti spiazzandoci. L’ho sempre percepito in perenne colluttazione con se stesso, sempre alle prese con un rigoroso – quanto silenzioso – esame di coscienza, sebbene questo non lo abbia mai portato a fare di noi figli il campo di battaglia dei suoi conflitti interiori. Non ci ha mai detto chi votare o a chi votarci, mai vietato amicizie o frequentazioni amorose, mai preteso che la pensassimo come lui. Non ci ha mai rovistato un cassetto, mai controllato un telefono, mai imposto una decisione senza prima spiegarci il perché. Lui, del resto, non ha mai imposto; ha sempre impostato. Non gli bastava crescerci, voleva accrescerci. Ci viziava senza vezzeggiarci, ci lodava senza incensarci, ci proteggeva senza scadere nella gelosia, ci avvolgeva senza mai abbracciarci – ché si ostenta l’amore che stenta, diceva scherzando, quasi a schermirsi della sua innata ritrosia agli approcci fisici -. Sapeva pure mortificarci, senza mai umiliarci però. Non ci alzava le mani, non alzava la voce, non sbatteva porte, non batteva pugni, non diceva mai “sono io che comando qui”.
La sua figura è stata un monumento alla sobrietà, un inno alla pacatezza, un capolavoro di pazienza e di temperanza. La resilienza – sebbene odiasse questo termine persino più di me – è stata la sua stella polare. Fino alla fine, quando ormai la morte gli aveva conficcato gli artigli fin dentro le viscere, ha cercato di proteggerci dissimulando il dolore, sfidando la spossatezza, addomesticando i tremori della voce, proteggendo una parvenza di serenità familiare che sentiva minata dalla sua malattia. È rimasto aggrappato a noi fino allo spasimo della sua ultima cellula, fino all’ultimo scampolo di vita, fino all’ultimo sussulto della sua coscienza. Sì è spinto fino all’estremo. Fino allo stremo.
Mi fermo, ché qui si rischia l’imbarcata di retorica sennò. E non c’è sgarbo più grande che potrei fargli se non quello di richiamarne e ricamarne la memoria con ampollosi panegirici o con stucchevoli agiografie. Non era né santo né eroe papà. Era uomo però, e non ha mai tradito mezza volta la sua concezione straordinariamente nobile di ciò che significasse esserlo. Non mi pare poco.
Morto un papà non se ne fa un altro.
E chi lo vuole un altro. Chi lo avrebbe voluto mai.
Buon viaggio amore mio. Ci vediamo là.